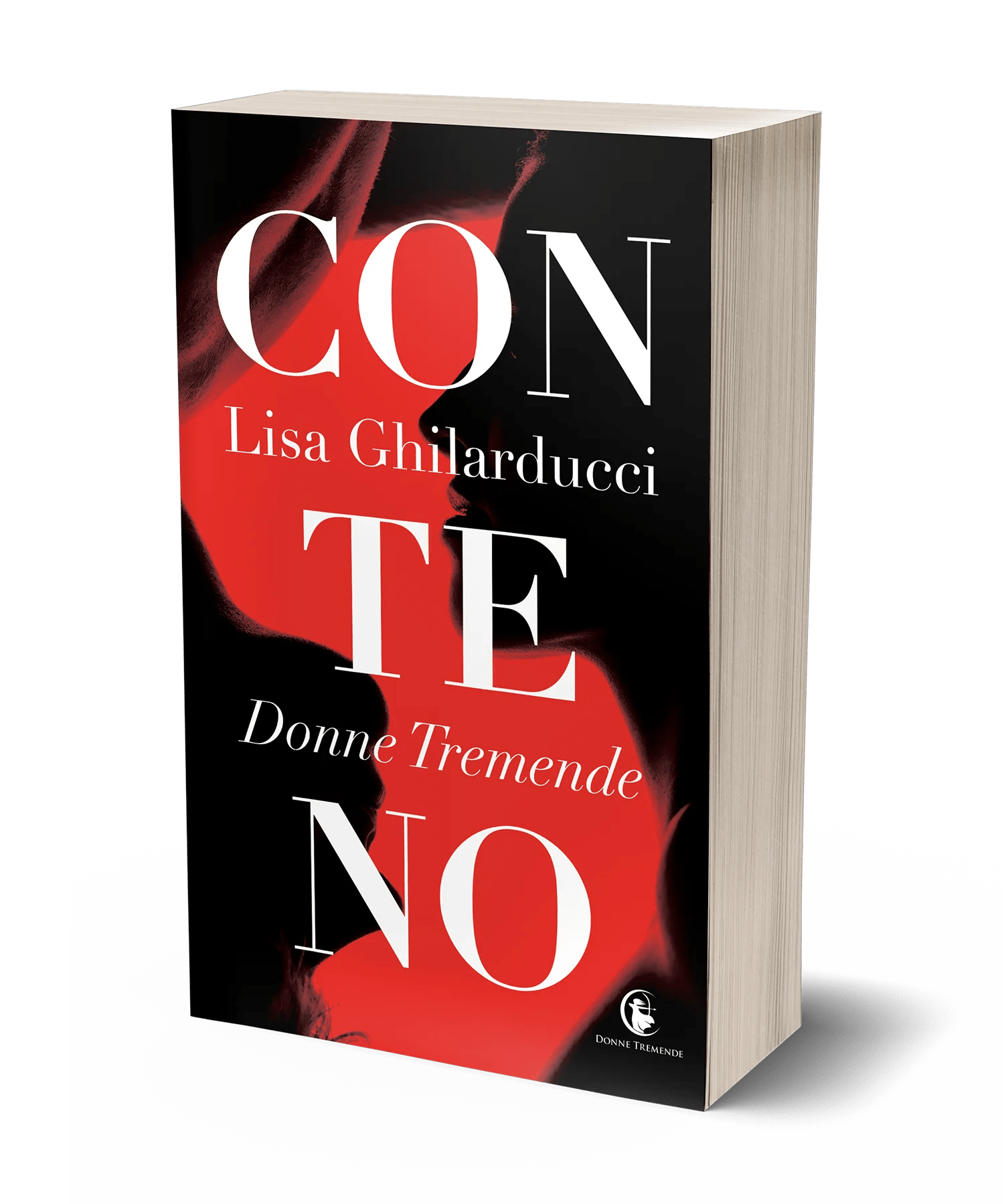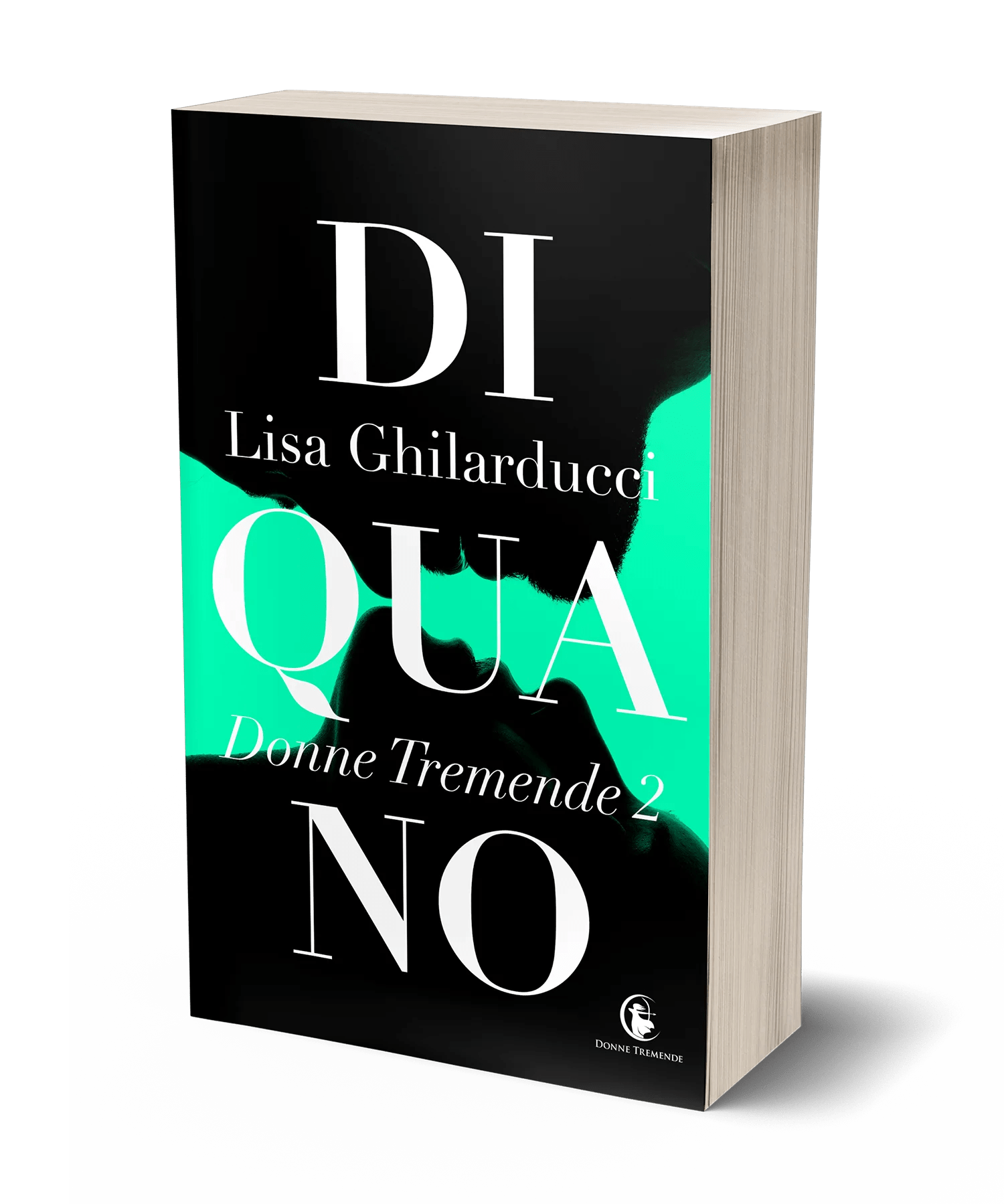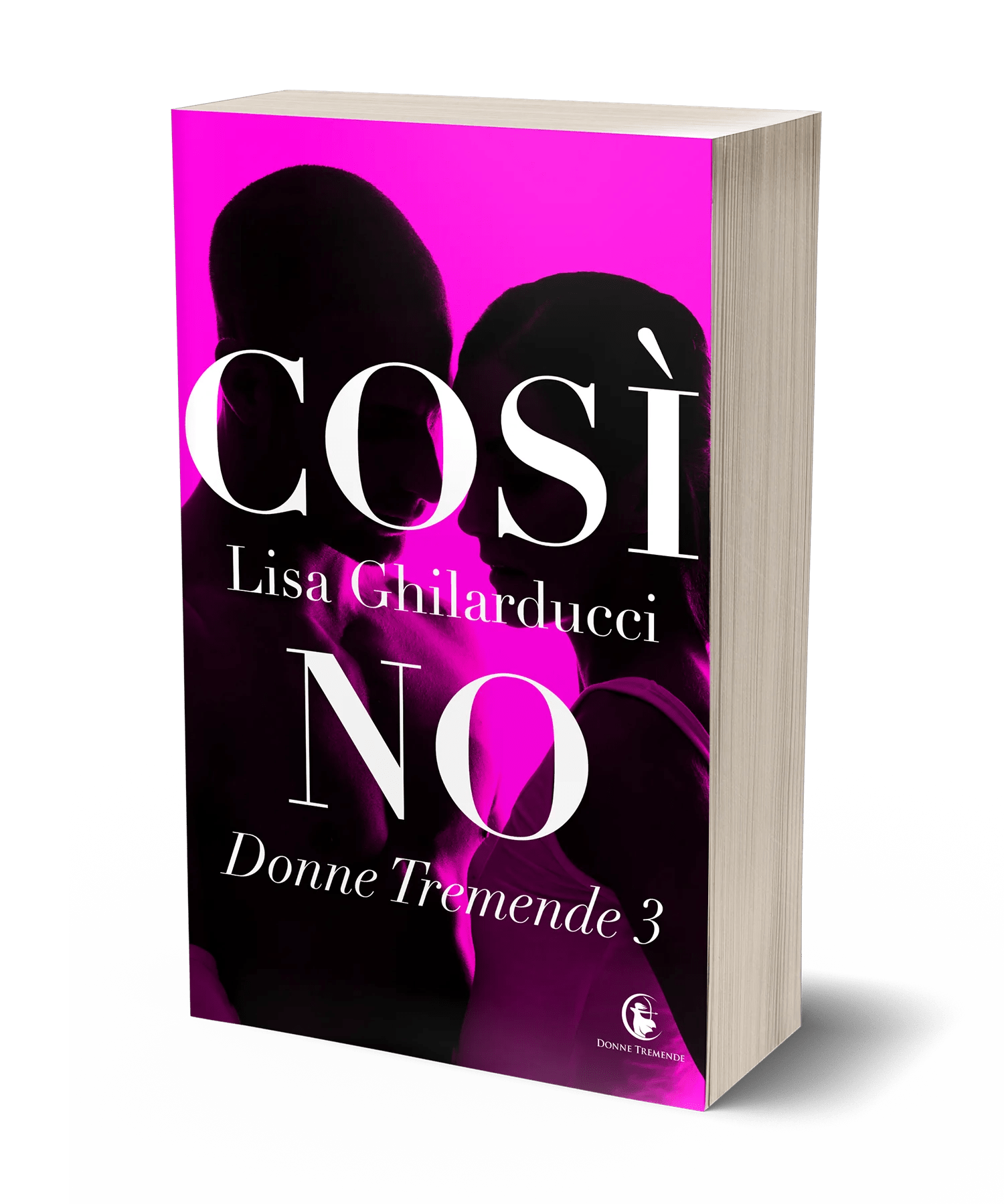Nel 2022 Procida diventa Capitale italiana della Cultura. Il titolo del suo delizioso divertissement reca Δία, accusativo di Ζεύς.
Ci spiega cosa s’intende per Diacultura?
Parto da lontano; ho scelto da un po’ di anni un modo di lavorare sui testi antichi anche sul versante della invenzione letteraria (teatro, monologhi, racconti ecc.), per puro divertimento, ma con l’intento di far riflettere comunque sul pensiero, anzi sui pensieri antichi, in comparazione con le nostre esperienze di uomini e donne (di qualsiasi età) degli anni duemila. Non mi sono accontentato della ‘riscrittura’, almeno di quella tradizionale, in cui si prende un mito e lo si trasferisce in un altro contesto, manipolandolo in vari modi; ho tentato di far vivere nello stesso contesto temporale passato e presente, con tutti i loro linguaggi; dando quindi anche ai personaggi antichi o mitici la possibilità di vivere nel nostro presente e di usare le nostre categorie e le nostre conoscenze (cinema, letteratura ecc.). Nel mio precedente volumetto (sempre per Liguori editore e per la cara amica Maria Liguori), dal titolo Il segreto del Tuffatore. Vita e morte nell’antica Paestum (2020), ho fatto sì, per esempio, che il narratore, uno degli amici del tuffatore effigiato sulla famosa tomba scoperta nel 1968, conoscesse i romanzi di Murakami o un film di Paolo Sorrentino. Avevo, quindi necessità di un nome che indicasse questo metodo di scrittura e ho pensato a un sapere che percorre, che attraversa i secoli, accumulando conoscenze e usandole in sincronia: la preposizione greca διά (che indica anche la percorrenza, l’attraversamento, e non solo) si prestava bene al compito, quindi diacultura. Poi, nel volume di cui parliamo, ho giocato su Δία, con cambio di accento, accusativo di Ζεύς, per quello che mi serviva nel racconto. Preciso solo che nel riscrivere, manipolare, intrecciare passato e presente, cerco di salvaguardare una conoscenza professionale del mondo antico mai banalizzata.
Lei, Professore, pone personaggi del mito e della storia letteraria sull’isola di Procida, tessendo incroci davvero originali.
Su quali rapporti cronologici ha fondato il suo sguardo dialogico?
Non rispetto le compatibilità cronologiche, proprio per il metodo ‘diaculturale’ scelto, o almeno fin quando non creino rapporti troppo stridenti. In qualche modo, cerco di rendere le incompatibilità, come si dice oggi, sostenibili, cioè capaci comunque di stimolare riflessioni, acquisizioni culturali. Quanto alle incompatibilità spaziali, vale lo stesso criterio, purché, di nuovo, alcuni mitemi (cioè singoli frammenti di un mito) possano essere incastrati come tessere di un mosaico, in questo nuovo racconto. L’occasione di Procida capitale della cultura 2022, unita al mio amore per quest’isola che si distingue da quelle cugine (o sorelle) di Capri e Ischia, molto diverse, mi ha spinto a ripercorrere molti luoghi procidani cui sono legato per collocarvi personaggi del mondo antico.
Gli dei durante un’assemblea si accorgono che “per loro è finita (…) perché sono troppi e con troppe specializzazioni”, così dal porto alla Chiaiolella, dal faro a piazza Olmo gustano la “la lingua di bue” oppure incontrano Gaber. Quali sono i reciproci apporti?
Insisto su un tema della mia prima risposta, andando più a fondo. Gli/le antichisti/e, o i/le docenti di lettere e lingue classiche in genere, hanno il compito di interpretare e portare alla conoscenza di alunni e alunne (a scuola e all’università, ma anche, con seria divulgazione, ad aree più ampie di pubblico), la cultura antica, creata, praticata e diffusa da persone in carne e ossa, anche se da noi lontane e non più interrogabili. In qualche modo abbiamo un debito con loro, dovremmo conservare l’onestà intellettuale di raccontarli per come erano realmente e per loro stessi, senza usarli per nostri fini particolari. Visto che questo è possibile fino a un certo punto (proprio per l’impossibilità di un dialogo diretto, ma solo utilizzando scritti o monumenti, che però siamo sempre noi a interpretare e tradurre) allora ho aggiunto la possibilità di fornire loro esplicitamente i nostri strumenti e la nostra cultura, perché si notino meglio le differenze fra le rispettive culture e siano loro stessi a sottolinearle. Questo, lo ricordo, in un procedimento di fantasia letteraria, ma non escludendo di poter dare qualche utile insegnamento alla nostra professione di antichisti, per svolgerla al meglio in un mondo così diverso da quello del secolo scorso, in cui molti di noi si sono formati/e.
Lei ripercorre una storia ininterrotta, che va dalla narrazione mitica ed arriva fino ad oggi.
Cosa ha inteso illuminare, sottraendolo al buio della nostra dimenticanza?
In primo luogo, il fatto che abbiamo a che fare sempre con uomini e donne che hanno agito, vissuto, scritto (più gli uomini che le donne), tentando di costruire comunità, affrontare avversari, ponendosi il problema della vita e della morte e dell’oltreumano. E quindi che anche noi dobbiamo trovare con e fra i nostri contemporanei la soluzione ai tanti problemi; io avverto un forte disagio quando sento qualcuno dire che ha imparato dagli antichi, per esempio da Platone, o da Seneca o da Cicerone. Come se li avesse come compagni di viaggio nel presente e fossero in grado di capire il presente, così diverso dal loro presente. Si tratta, evidentemente, di una finzione, di un modo di affermare che ci sono verità eterne, che resistono alla prova del cambiare dei tempi e delle mentalità, e delle persone stesse. A me pare un’affermazione di comodo, a volte anche un po’ elitaria (in realtà solo chi ha fatto il liceo classico o è un lettore informato potrebbe usufruire di tali insegnamenti). La storia, invece, ci fa capire che tutto è sempre più complesso, più variegato, più soggetto a tanti punti di vista, e che prima di emettere un giudizio, prima di formulare un’affermazione categorica, sono tante le analisi da fare (penso soprattutto alla rapidità della frase da social, sempre giudicante, sempre perentoria). Ecco, per ricordare questo compito di intelligenza critica ben vengano i racconti diaculturali, che abituano a pensare e analizzare prima di parlare.
Può indicarci un particolare della “sua” Procida, un elemento per lei inconfondibile?
Io sono legato, per la storia del mio primo approccio all’isola, al faro, che è contemporaneamente vicino e lontano dal porto di approdo dei traghetti. E poi il faro ha una scogliera e un fondale sempre nuovi da scoprire; la lunga e stretta strada che porta al faro mi è spesso sembrata come il tracciato di un nostos, dalla mondanità e dai rumori del centro dell’isola al silenzio dell’incontro col mare. Magari per altri sarà differente, ma quando arrivo a Procida col traghetto e intravedo il faro; poi, con piccola deviazione, raggiungo il Porto, so che c’è ancora la strada del nostos, quel tratto da percorrere mentre i pensieri sono ormai dentro l’isola, protetti. E al faro ho fatto arrivare Filodemo, il primo autore antico che ho studiato a fondo sui papiri ercolanesi: a un faro che non era il faro che lui cercava, ma forse lo appagò di più.
Gigi Spina ha insegnato Filologia Classica all’Università Federico II di Napoli ed è stato Chaire Gutenberg 2009 all’Università di Strasburgo; è stato segretario dell’Associazione Antropologia e Mondo Antico.